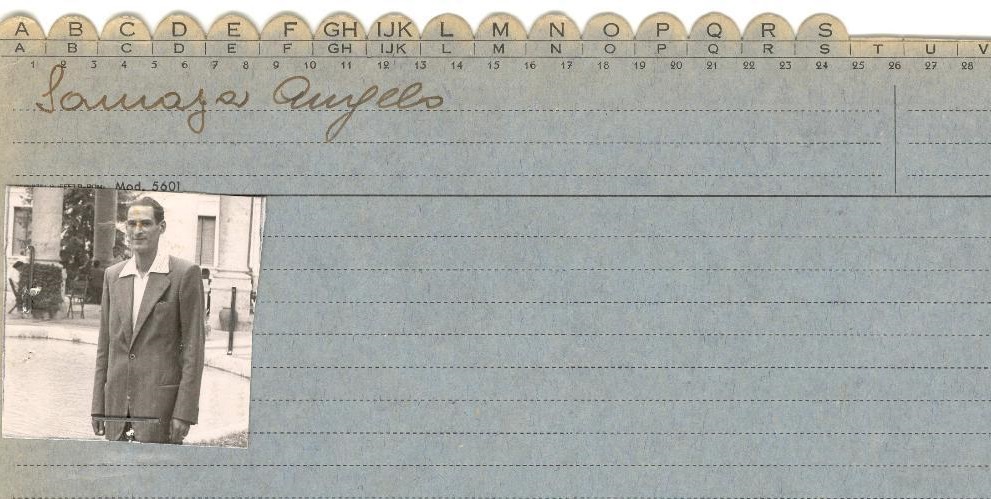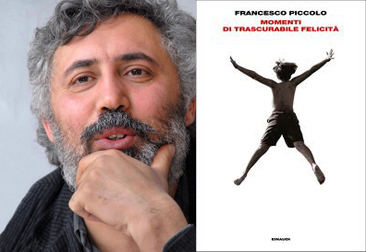Una riflessione sull’eredità di Papa Francesco
Pensando alla morte di Papa Francesco – ormai alcuni giorni fa – alle immagini di un popolo in cammino per dargli l’estremo saluto e alle immagini storiche del suo funerale, e’ facile pensare all’unicità di una leadership di ampiezza globale. Una capacità che adesso si confronta con la parte più complessa della fase post-mortem: l’eredità. Il lascito di un messaggio cui non poche volte si sono attivamente o passivamente opposte personalità politiche o spirituali che pure erano presenti alle sue esequie. Nel provare a mettere assieme una riflessione sulla morte del Papa, finalmente a mente fredda, posso resocontare di aver percepito ed elaborato due sensazioni. Due specifici approcci che, a mio avviso, dicono anche qualcosa della relazione col suo messaggio. Del resto: tanto e’ stato scritto, tantissimo sarà detto e, una volta che il nutrimento delizioso per le storiche e gli storici – gli archivi – saranno messi a loro disposizione, ancora di più sarà studiato ed elaborato. Meglio, insomma, addentrarsi su qualcosa di contemporaneamente “politico” e “personale”, chiaramente senza la pretesa di perfezione.

Stupore. Pur riconoscendo che, dopo Giovanni Paolo II nel 2005, l’opinione pubblica è “tornata” a vedere un Papa invecchiare, indebolirsi e morire, nell’aspettativa della medesima opinione pubblica generalista permaneva una tendenza alla sorpresa. Tale sensazione e’ stata la mia stessa, identica, sensazione. Non ce lo aspettavamo e non me lo aspettavo perché, se il giorno prima della propria morte, ci si affaccia dalla Loggia della Basilica di San Pietro per impartire, seppur gravato dalla fatica, una benedizione Urbi et Orbi o si incontra il Vicepresidente degli Stati Uniti, con cui la rivalità geopolitica e antropologica è ai massimi livelli da sempre per la Santa Sede, la possibilità di una morte improvvisa non rientra tra i pensieri possibili o le opzioni realisticamente in campo. Invece, la fragilità è sempre presente: proprio la testimonianza costante di questa fragilità è stata la cifra degli ultimi mesi del pontificato. Attendere l’esito di questa fragilità fa parte della vita, e soffrirne è lo strumento per ricordarsi quanto valgono le persone amate (e, tante volte, dimenticate): vale nello spazio del privato con le persone care, vale nello spazio pubblico e politico, dove è sbagliato definire sulla vita degli essere umani assunti intangibili, ritenendo che saranno lì per sempre, senza un cambio di fase – sanitario o altro che sia. Se ci pensiamo bene, la cognizione della fragilità e’ stata al centro della sfida italiana e mondiale del tempo della pandemia. Sfida che ha visto Papa Francesco in primissima linea, con un richiamo incredibile, da Piazza San Pietro vuota al mondo intero, il 27 Marzo 2020:
Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme.
La sfida della cura, del prendersi carico del prossimo, dell’attenzione a ciò che è spesso dimenticato: la vita, la socialità, la relazione. Quanto e’ stato dimenticato tutto questo? Quanto il ricordo delle fragilità della pandemia e’ stato obnubilato dal ritorno frenetico al normale, dalla corsa al riarmo, dal riallineamento con l’ordine “antico”? Nei dossier di politica nazionale e globale quel riferimento all’epidemia è ormai limitato, al massimo inserito nel concetto generale di “preparedness”, preparazione – di sapore più militaresco che sociale o civile. Sul piano individuale, il decesso “improvviso” di Francesco, per quanto preceduto da settimane di sofferenza con quasi 40 giorni di permanenza in ospedale, ricorda come a volte dare per scontate le persone nella nostra immediata prossimità sia un rischio ricorrente. Gli esseri umani, proprio perché fragili, invece, potrebbero non esserci più, e tale assunto tanto banale sembra quasi dirompente in una società performativa, frettolosa e stressante in cui i nostri spazi di relazione sono immersi. A volte, lo dimentico anch’io. E nello “stupore” per la riscoperta della morte, Francesco ha quasi involontariamente ricordato quella fragilità della vita, quelle vulnerabilità che ha sempre rammentato nella dimensione pubblica, spirituale, e involontariamente politica.
Gratitudine. A prescindere da come si possa pensare a specifici temi politici, spirituali o sociali, il “Papa venuto dalla fine del mondo” ha utilizzato con saggia spregiudicatezza le strutture della Chiesa bimillenaria per “investire” in un “investimento antieconomico”: rendendo quella comunità spirituale globale un “ospedale da campo”: una espressione straordinaria, scolpita nell’intervista rilasciata da Papa Francesco alla rivista La Civiltà Cattolica nel corso di tre appuntamenti il 19, il 23 e il 29 agosto 2013.
Bisogna cominciare dal basso. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. E’ inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto.

Uno spazio pubblico di misericordia. Una testimonianza attiva di pace. Rimanere fedeli alla complessa fedeltà al Vangelo, con tutte le contraddizioni del nostro tempo, con un’intera eredità a cui essere fedeli senza snaturare il messaggio della fede cristiana: una sfida che non è mai stata facile. Qui in Europa, abbiamo assistito a volte con sgomento a queste parole, a queste scelte, a queste azioni – basti pensare alla visita a Lampedusa dell’8 luglio 2013, primo anno del suo pontificato.
Il discorso sulle migrazioni e’ stato ripetutamente incrociato con un altro tema ricorrente: la pace. La persona migrante e’ stata individuata come una “opportunità per costruire questa cultura”, come indicato nel discorso ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti nel 2013. Tra le vulnerabilità indicate come centrali nel magistero, figurano certamente le povertà antiche e nuove: i poveri sono stati indicati come “protagonisti dell’evangelizzazione” nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium del 2013. Un magistero di ascolto e attenzione, anche su temi di dura contraddizione per la cattolicità, a partire dal ruolo delle donne, dall’inclusione di divorziati/e e separati/e, dall’equità per gli orientamenti sessuali.
Su ciascuno di tali argomenti ci sarà un tempo per l’analisi storica critica, così come il tempo giusto per le polemiche su parole e scelte politiche inaccettabili. In questo gruppo, non è possibile dimenticare la riflessione del Papa sui diritti riproduttivi «Un aborto è un omicidio, si uccide un essere umano. I medici che si prestano a questo sono, permettetemi la parola, sicari» o sulla effettiva pari dignità di orientamento sessuale: questo è molto importante, e sarà essenziale farlo con la capacità di calare nei contesti le parole, le scelte, le azioni, le omissioni – senza alcuna remissività, senza alcuno smussamento semplicistico, senza alcun cedimento verso tutta la parte pur inclusiva del magistero del medesimo pontificato. E nella consapevolezza che quell’umanesimo integrale e con vocazione cosmopolitica di cui Papa Francesco è stato alfiere indiscutibile si è nutrita, nelle prassi, di una tendenza accentratrice di marca populista, come ha sottolineato Nadia Urbinati alcuni giorni fa su Domani. Allo stesso tempo, quella stessa attenzione ai temi sociali e quella stessa apertura tollerante a generi e orientamenti sessuali non può essere disgiunta dalle radici esistenziali e spirituali del profilo stesso di Jorge Mario Bergoglio. Quando, ad esempio, si pensa alla faticosa decostruzione dell’immaginario maschile nella Chiesa Cattolica – ne scrissi qualche anno fa per Jacobin – andrebbe ricordato come Francesco fosse in linea con l’inserimento delle donne nella battaglia per la declericalizzazione della Chiesa, laddove il clero (e in particolare la successione episcopale) esprime un ruolo totalizzante del genere maschile. Nella declericalizzazione, basata sull’eguaglianza battesimale tra generi, vi è il ruolo del servizio alla Chiesa, anche in suoi livelli gerarchici non indifferenti come le prefetture dei dicasteri pontifici. Tuttavia, resta insoluto il ruolo della donna nella ministerialità ordinaria, fonte primaria dell’esercizio del potere nella comunità dei credenti. Allo stesso tempo, gli elementi di “apertura” verso il mondo LGBTQI sono basati su misericordia, accettazione: nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, egli rammentava come «ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare “ogni marchio di ingiusta discriminazione” e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza». Alle comunità ecclesiali, essendo in corso il Sinodo dei Vescovi, si chiedeva di impegnarsi in un “doveroso accompagnamento”: non (più) verso terapie riparative, più o meno forzate, ma “per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita”. Tuttavia, le possibilità concrete di condivisione di una strategia integrata di condivisione di diritti civili pieni da parte dell’indicazione magisteriale cattolica non potrebbe essere fattibile se non a prezzo di un più ampio aggiornamento dottrinale: circostanza impraticabile non solo per rapporti di forza nel clero, quanto per una difficoltà effettiva di un pontificato che provava (a fatica e spesso con contraddizioni dovute all’esercizio spregiudicato dell’autorità pontificia) a tenere assieme la netta radicalità di un’apertura al mondo con la continuità dell’istituzione nel suo complesso. Da qui l’opzione per una via disegnata sul cammino della misericordia e che, alle orecchie di chi vive percorsi di attivismo, può risultare paternalistica, limitante, anti-storica, essenzialmente una riverniciatura inclusiva del medesimo approccio maschio- ed etero-centrico. Tuttavia, tale percorso, per quanto complesso e con esiti non scontati, ha avuto almeno due pregi, specie se letto col prisma interpretativo del cattolicesimo statunitense – il piùo stico per Papa Francesco. Il primo è stato di aprire una via di ricerca inedita e radicale per quelle parti del clero, dei laici, delle comunità ecclesiali e di studio teologico tesi a prendere davvero di petto la questione, come dimostra il caso dello studioso gesuita James Martin. Il secondo è stato quello di costringere l’intera Chiesa, al di là di sfumature più o meno conservative o progressive, a tenere con maggiore saldezza nel magistero e nella prassi di intervento pubblico il tema della battaglia contro ogni discriminazione fondata sul credo religioso. Circostanza che, in un’epoca di estremismi monoteisti sempre presenti, non si puo’ derubricare a “riverniciatura”. Un pontificato, in buona sostanza, in cui permangono le contraddizioni del bilanciamento tra continuità e auto-riforma, mentre personalità e movimenti collettivi, dentro e fuori la dimensione ecclesiale, sedimentano prassi, alleanze, prese di parola radicali su cui sarà necessario investire nel futuro.

A mio parere, come linea generale, sarebbe sciocco snobbare, che sia con piglio laicista o con postura cristiano-tradizionalista, la portata globale di una vita che Papa Francesco ha messo a disposizione della sua Chiesa e del mondo, dai credenti di altre religioni ai non credenti.
Ecco, in sintesi: lo stupore innanzi al senso di fragilità e la gratitudine per una vita donata sono le eredità che, sin dal giorno della sua morte, rimangono nella mia mente.
Arriverà – anzi, siamo già in quel momento – il tempo del pieno e legittimo diritto di inventario e contestazione storico, politico, religioso.
Nel frattempo, rivedo le immagini di quel discorso al mondo pronunciato nel mezzo della prima ondata della pandemia di COVID-19 in Italia, in una Piazza San Pietro vuota.
Ecco perché penso che Francesco non sia morto, ma sia vivo.
Per chi non ci crede: perché quel lascito non muore. Per chi ci crede: perché vive nella luce del Dio e del Vangelo in cui ha sempre creduto.
Ricordo, intanto, il coraggio di dire a quel mondo, come al nostro mondo: coraggio.
Nessuna, nessuno può salvarsi in solitudine. Grazie.
- Papa Francesco è morto. Francesco è vivo - 1 Maggio 2025
- Leggi Razziali: Perdono, tra passato e presente - 23 Ottobre 2018
- Il ventre delle banlieues nelle parole di Pier Paolo Piscopo - 1 Settembre 2018