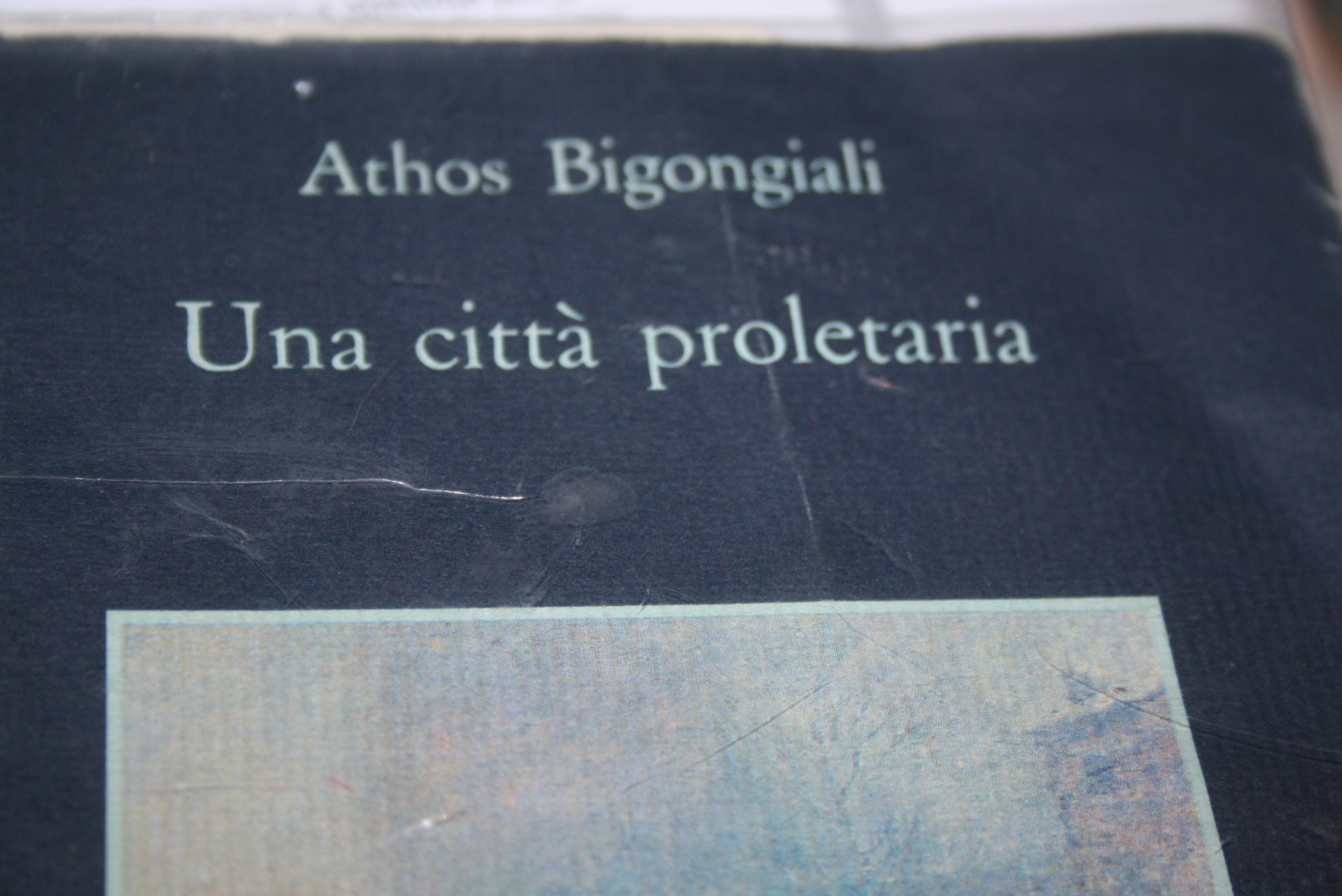Athos Bigongiali: «Quella censura che mi spinse a scrivere Una città proletaria»
PISA – Una città proletaria, il primo romanzo di Athos Bigongiali, fu pubblicato da Sellerio nel 1989 «come antidoto ai tempi in cui viviamo». Bigongiali racconta che una sera stava guardando alla televisione Sacco e Vanzetti, il film del grande Giuliano Montaldo, che aveva già visto anni prima al cinema. Rimase colpito dal fatto che, nel film per la tv, era stata tagliata una scena. Quando portano Vanzetti, verso la sedia elettrica, lui (Gian Maria Volonté) si volta e dice: «Viva l’anarchia». Scena tagliata, «Viva l’Anarchia» cancellata.
Siamo a fine anni Ottanta, c’era Craxi, eravamo agli albori del berlusconismo, cominciava una stagione politica che prometteva un «nuovo miracolo italiano», un milione di posti di lavoro, era cominciata la seduzione della “Milano da bere”, c’erano gli yuppies, i giovani rampanti e di successo, ma allora era ancora ben presente la memoria di un’Italia proletaria e di una Pisa proletaria, c’era ancora il Pci, i partiti con i loro militanti, i partiti che gli anarchici vedono come il fumo negli occhi. Però qualcuno vedeva anche il rovescio della medaglia: «Stiamo vivendo un tempo di sub ideali… Quando ti innamori il cuore batte, qui invece non batte niente, c’è una disforia interna e un’euforia esterna…». Così Antonio Tabucchi già nel 1980.

C’era tutto questo, ma niente «Viva l’anarchia». Mi dice al telefono fisso Athos: «Rimasi esterrefatto, che senso ha cancellare quella frase? Quella stupida censura mi provocò un primo moto di sdegno. Di cui mi ricordai anni dopo, in occasione del convegno sulle origini della Camera del Lavoro pisana, dove appresi che la censura riguardava anche la storia del movimento operaio: gli anarchici e l’anarchismo erano scomparsi o relegati in note a pie’ di pagina». Allora si accese in lui una scintilla etica: «La Camera del Lavoro a Pisa per anni era stata guidata da anarchici, migliaia di operaie tessili capitanate da donne, alcune sono tumulate al cimitero di Pisa, se vai nella loggia dei cremati incontri i nomi di donne anarchiche dichiarate come Priscilla Fontana, autodidatta, nota per la ricostruzione delle Leghe e per le sue battaglie sindacali. Così, dallo sdegno per aver cancellato una parte dalla nostra storia, crebbe in me una curiosità interiore che mi spinse a scrivere questo libro. Ci lavorai due anni, tra ricerche e scrittura. Che fu, la scrittura, subito impostata sul romanzesco, come era nelle mie corde: una scelta felice visti i risultati».
Poi Luciano Della Mea, autodidatta e libertario come tanti anarchici descritti in questo libro, “il Mea”, che si definiva «socialista di sinistra», con il suo intercalare fatto di «Ostrega» che mi porto ancora dietro perché ho avuto la fortuna non solo di conoscerlo ma di lavorarci insieme per fare un giornale che si chiamava guarda caso Unità proletaria, suggerì a Bigongiali di scrivere a Elvira Sellerio per pubblicare il romanzo. Ricorda Bigongiali: «Glielo spedii con una lettera in cui educatamente le dicevo che avevo trovato inverosimile la notizia che lei leggesse tutti i dattiloscritti che le arrivavano, e le dissi: Ecco una storia che può essere inverosimile, però è vera». Dopo sei mesi dall’invio del dattiloscritto, fu buffa la telefonata tra i due. «Pronto, sono Elvira Sellerio…». Bigongiali, scrittore esordiente, pensò a uno scherzo, perché aveva detto ad alcuni amici che le aveva spedito il manoscritto e rispose alla pisana: «Seee!». Invece era lei davvero, ricorda Athos: «Persi la voce, non me l’aspettavo, diventai afono».
Così cominciò la fortuna di Una città proletaria, che diventò il libro numero 217 della prestigiosa collana di narrativa La Memoria, entrò nella classifica dei libri più venduti, ebbe come primo recensore Remo Ceserani su il manifesto.
Prosegue Bigongiali: «Io avevo intitolato il romanzo La città dei malfattori, la Sellerio (forse su suggerimento di Sciascia) lo cambiò in Una città proletaria. Il risvolto di copertina mi fu letto da Elvira Sellerio al telefono e, quando io le chiesi chi lo avesse scritto, lei rispose: “Il migliore di noi”. E anche quando diventammo amici non volle mai aggiungere altro. Mi ha fatto un grande onore, le sarò grato per sempre, che vuol dire per poco», conclude Athos un po’ alla Tabucchi, a cui il libro piacque molto.
La fortuna di Una città proletaria continuò con lo spettacolo teatrale nel 1991 grazie Paolo Pierazzini e Francesco Bruni, e nel 1992 quando fu allestita l’opera lirica intitolata Il Paradiso degli esuli, con musiche di Bruno de Franceschi, libretto di Stefano Del Seta e regia dello stesso Pierazzini.

Uno striscione per Franco Serantini, a Pisa, il 7 maggio 1973. (fonte: La Nazione)
Le vicende, narrate da più voci, si svolgono a Pisa nel primo Novecento. Non c’è un vero protagonista, ce ne sono molti. Pietro Gori e un mondo di anarchici dai nomi improbabili e anticonformisti: Pompeo, Pirro, Acratica, Nilo, Sguardo, Jessa, Selica, Catullo, Gusmano, Priscilla, Ricciotti, Germinal. Personaggi che, già dal nome, manifestano la propria estraneità allo stato di cose presenti col rifiuto di chiamare i figli con i nomi dei santi del calendario. Il lavoro poggia su solide basi documentali, grazie a una ricerca dell’autore su fonti di prima mano reperibili nelle biblioteche cittadine come la Biblioteca Franco Serantini diretta da Franco Bertolucci. Alla base della narrazione ci sono anche gli studi di Lorenzo Gestri e di Alessandro Marianelli, l’amico Sandro, due storici del movimento operaio.
La storia del movimento anarchico e libertario corre sempre il rischio di essere dimenticata e gran merito di questo romanzo è contrastare questa perdita di memoria, raccontarcene uno squarcio locale significativo, fuori dai gravami che potrebbero esserci quando la storia di un partito è scritta da uno storico di quel medesimo partito o da uno studioso con quell’orientamento politico.
Prendiamo il contesto, Pisa in quegli anni era la terza città più industrializzata d’Italia, Bigongiali lo scrive fin dall’introduzione. Ma Pisa era anche la terza città italiana, dopo Carrara e Ancona, dove la presenza anarchica allora era più forte. In un dispaccio del reporter americano di nome Jack, si immagina che Jack sia John Reed ma in ogni caso dice cose vere come quando si chiede: «Quanti sono gli anarchici di Pisa?… consultando i lunghi elenchi delle sottoscrizioni pubblicati dall’Avvenire… mille compagni e cinquemila sostenitori: per le cose che ho visto non ritengo il calcolo eccessivo» (UCP, pp. 142-143).
Nel capitolo intitolato Conti alla mano Bigongiali cita una nota del Ministero degli Interni del 1912 che «aveva stimato in 9148 gli anarchici italiani cosiddetti “attivi”. Una minoranza visto che i repubblicani erano trentamila e i socialisti quarantamila… Ma nel 1914… gli anarchici erano saliti a diecimila, divisi in 204 associazioni… gli anarchici pisani erano 625, i terzi per numero dopo i carrarini e gli anconetani» (UCP, p. 106). I pisani si burlavano di queste cifre, perché riguardavano solo gli “schedati”, gli anarchici pisani erano quasi il triplo e lottavano contro il carovita e la guerra di Libia. Se poi si guardano i dati del censimento del 1901, si legge nel romanzo: «I residenti dichiaratisi “non credenti”: 491 maschi e 352 femmine. Da sommare con quelli che si erano rifiutati di dichiarare la propria religione: 2713 maschi e 2899 femmine… Senza Dio, senza patria e senza padroni questa Pisa!».
Un mondo anarchico, appunto.
Ma Una città proletaria non è un saggio storico, è un romanzo che va ben oltre la figura dell’anarchico isolato, regicida, dinamitardo, bombarolo e attentatore, che pure è esistito ed è menzionato in questo libro, che ha il merito di ricordarci come gli anarchici «erano per nulla sedotti dal clima progressivo dell’età giolittiana» (UCP, p. 49).
Basterebbe questo per salutare il ritorno, nel 2016, di Una città proletaria nelle librerie grazie a MdS, «un editore giovane, serio e coraggioso», con una nuova prefazione, l’aggiunta di qualche capitolo e alcune schede di polizia. E con una nuova copertina di Carmine Santangelo. Un corteo in una città che sembra Pisa: il lungarno, i palazzi sulla sinistra e il fiume sulla destra. Dice Evening: «La Storia è una serie ininterrotta di significati. Oscurarne uno non darà più luce ad un altro. È un lento fiume che scorre dice il gentiluomo. Immutabile e che sempre muta. Come la verità, come quest’Arno» (UCP, pp. 32-33). Ad aprire il lungo fiume del corteo, sulla destra c’è Franco Serantini, eterno ventenne, purtroppo. Sulla sinistra mi pare di vedere la bella faccia di Fabrizio De André. Sullo sfondo sfila il ruvido e gentile anarchismo di massa fatto di tanti volti e vite che il Bigongiali ricostruisce con talento.
Il libro di Bigongiali ci colpisce ancora dopo quasi trent’anni. Perché racconta storie vere dentro una bugia. Bigongiali costruisce una storia romanzesca dove si mescolano memoria, voci, un mondo anarchico vitale. Che è proprio il contrario della cosiddetta fuga dalla realtà, «un racconto dedicato ai vinti e questa è l’unica lezione che mi sento di sottoscrivere di fronte ai lettori, vecchi e nuovi» (UCP, p. 6).
Il libro comincia con il verso più noto della canzone di Pietro Gori: Nostra patria è il mondo intero. Questa parola d’ordine non era soltanto un’aspirazione o una frase a effetto per il comizio della domenica. Era qualcosa che apparteneva alla vita degli anarchici.
Bigongiali è bravo a riempire i taccuini sgualciti di “Evening, redattore dell’Avvenire Anarchico di Pisa” con le cronache dei funerali di Pietro Gori (cap. ottavo), che durano tre giorni, dal Porto di Piombino all’alba del 9 gennaio 1911 fino al Cimitero di Rosignano nella mattina del 10 gennaio 1911, le pagine del taccuino di Evening testimoniano l’affetto, le poesie, le canzoni che faranno di Pietro Gori un mito.
Nel romanzo, nella cronaca romanzata dei funerali, si accenna a quando «Pietro Gori salpò per l’America». Pietro Gori è un mito e un esempio concreto di internazionalismo. Durante il suo esilio forzato negli Stati Uniti, e soprattutto in alcuni paesi del Sudamerica, si dedicò all’attività politica e scientifica. Fu capace di trasformare l’esilio da strumento di riparo contro la repressione in un’occasione di militanza politica, sindacale e ideale per la diffusione delle idee libertarie tra gli immigrati italiani in cerca di fortuna. Pietro Gori si sente “a casa sua” non nell’Italia colonialista di Crispi o nell’Italietta di Giolitti, ma ovunque sia possibile organizzare i lavoratori, italiani e non, per una lotta di liberazione.
Nello spazio di un romanzo di neanche duecento pagine ho trovato molti spunti di riflessione che ruotano attorno a una domanda: le vite e le idee di questi anarchici, in primis quelle di Pietro Gori che leggiamo in Una città proletaria, l’anarchismo, le idee libertarie sono definitivamente tramontate o hanno ancora qualche attualità?
Per esempio, la critica del potere, anzi il rifiuto del potere, dello Stato e del partito da parte di questi «cavalieri dell’ideale» che fanno tesoro del motto «governa te stesso» (UCP, p. 17); l’internazionalismo espresso molto bene nel verso di una canzone anarchica di Pietro Gori: Nostra patria è il mondo intero; la capacità di utilizzare linguaggi e strumenti diversi. Naturalmente ognuno di noi avrà le sue idee sull’anarchismo. Io sento una “amicizia delle idee” e credo che esistano elementi di attualità che emergono dalla lettura di Una città proletaria.
Mi soffermo soltanto su un tratto della figura di Pietro Gori come emerge dalla ricostruzione dei suoi funerali in Una città proletaria, ma si tratta di un elemento diffuso in tutto il libro, non saprei come definirlo, per usare una parola cara a Luciano Della Mea, direi politecnico. Per esempio Pietro Gori era un avvocato, un uomo colto, che con grande intelligenza e una certa modestia usava più linguaggi e strumenti: dal comizio all’opuscolo, dalla rappresentazione teatrale fino al canto popolare. Oggi, forse, la parola giusta sarebbe multimediale. Lui era il maestro, ma gli anarchici con lui riescono a catturare l’immaginario popolare. Proviamo a immaginare l’impatto che quelle canzoni, specialmente Addio Lugano bella, ebbero allora e quanto lo hanno avuto in futuro. Colpirono anche la mia tata-nonna Velia, che era una persona intelligente, ma aveva fatto sì e no la quinta elementare, era saggia e a suo modo colta, era nata nel 1901 a Molina di Quosa, aveva dieci anni quando morì Pietro Gori, spesso mi recitava questi versi:
«Viva Pietro Gori e il suo ideale
Abbasso quell’infame borghesia
Abbasso le catene del tribunale
Abbasso i preti
Viva l’anarchia»
- Tabucchi e la Fiab per una domenica di luoghi e ricordi - 21 Gennaio 2023
- Viva Tabucchi! Oggi più che mai - 23 Settembre 2017
- Il filo dell’anarchia in “Una città proletaria” - 22 Agosto 2017